La formazione
In Sardegna
Antonio Gramsci nacque ad Ales, presso Oristano, da Francesco (1860 – 1937) e Giuseppina Marcias (1861 – 1932). [1] Francesco, originario di Gaeta, di famiglia medio-borghese, era studente in legge quando morì suo padre, colonnello dei carabinieri; dovendo trovare subito un lavoro, nel 1881 partì per la Sardegna per impiegarsi nell'Ufficio del registro di Ghilarza. In questo paese, che allora contava circa 2.200 abitanti, conobbe Peppina, che aveva studiato fino alla terza elementare ed era figlia di un esattore delle imposte, nonché proprietario di alcune terre; malgrado l'opposizione dei genitori, rimasti in Campania, che consideravano i Marcias una famiglia di rango inferiore alla propria, la sposò nel 1883. Dal matrimonio nascerà Gennaro, nel 1884, e dopo che l’ufficio fu trasferito da Ghilarza ad Ales, Grazietta nel 1887, Emma nel 1889 e, il 22 gennaio 1891 Antonio, che fu battezzato il 29 gennaio.
L'anno dopo la famiglia si trasferisce a Sorgono, il paese di cui la madre è originaria, e qui nascono gli altri figli, Mario nel 1893, Teresina nel 1895 e Carlo nel 1897. Antonio, a due anni, si ammalò del morbo di Pott, una tubercolosi ossea che in pochi anni gli deformò la colonna vertebrale e gli impedì una normale crescita: Gramsci non supererà il metro e mezzo di altezza; i genitori pensavono che la sua deformità fosse la conseguenza di una caduta e anche Antonio rimase convinto di quella spiegazione. Ebbe sempre una salute delicata: a quattro anni, soffrendo di emorragie e convulsioni, fu dato per spacciato dai medici, tanto che la madre comprò la bara e il vestito per la sepoltura. [2]
Arrestato il 9 agosto 1898 con l'accusa di peculato, concussione e falsità in atti, Francesco Gramsci viene condannato il 27 ottobre 1900 al minimo della pena con l'attenuante del «lieve valore»: 5 anni, 8 mesi e 22 giorni di carcere, da scontare a Gaeta; priva del sostegno dello stipendio del padre, per la famiglia Gramsci furono anni di estrema miseria che la madre affrontò vendendo la sua parte di eredità, tenendo a pensione il veterinario del paese e guadagnando qualche soldo cucendo camicie. [3]
Proprio per le sue delicate condizioni di salute Antonio cominciò a frequentare la scuola elementare soltanto a sette anni: la concluse nel 1903 col massimo dei voti ma la situazione familiare non gli permise di iscriversi al ginnasio. Già dall’estate precedente aveva iniziato a dare il suo contributo all'economia domestica lavorando all'Ufficio del catasto di Ghilarza per 9 lire al mese – l'equivalente di un chilo di pane al giorno – per 10 ore al giorno, smuovendo «registri che pesavano più di me e molte notti piangevo di nascosto perché mi doleva tutto il corpo». [4]

Antonio Gramsci nel 1906
Il 31 gennaio 1904 Francesco Gramsci, grazie a un’amnistia, anticipa di tre mesi la fine della sua pena: inizialmente guadagnò qualcosa come segretario in una Assicurazione agricola, poi, riabilitato, fece il patrocinante in conciliatura e infine fu riassunto come scrivano nel vecchio 'Ufficio del catasto, dove lavorò per il resto della sua vita. Affrontando gli abituali sacrifici, i genitori poterono iscrivere il quindicenne Antonio nel Ginnasio comunale di Santu Lussurgiu, a 18 chilometri da Ghilarza, «un piccolo ginnasio in cui tre sedicenti professori sbrigavano, con molta faccia tosta, tutto l'insegnamento delle cinque classi». [5] Con questa preparazione avventurosa riuscì a prendere la licenza ginnasiale a Oristano nell'estate del 1908 e a iscriversi al Liceo Dettori di Cagliari, stando a pensione, prima in un appartamento in via Principe Amedeo 24 poi, l'anno dopo, in corso Vittorio Emanuele 149, insieme con il fratello Gennaro il quale, terminato il servizio di leva a Torino, lavorava per cento lire al mese in una fabbrica di ghiaccio del capoluogo sardo.
La modesta preparazione ricevuta nel ginnasio si fece sentire, perché inizialmente Gramsci ottenne nelle diverse materie appena la sufficienza, ma recuperò in fretta: del resto, leggere e studiare era il suo impegno costante. Non si concedeva distrazioni non soltanto perché avrebbe potuto permettersele solo con grandi sacrifici, ma anche perché l'unico vestito, per lo più liso, da lui posseduto, non lo incoraggiava a frequentare né gli amici né i locali pubblici. [6]
Il fratello Gennaro era tornato in Sardegna militante socialista e ai primi del 1911 divenne cassiere della Camera del lavoro e segretario della sezione socialista di Cagliari: «Una grande quantità di materiale propagandistico, libri, giornali, opuscoli, finiva a casa. Nino, che il più delle volte passava le sere chiuso in casa senza neanche un'uscita di pochi momenti, ci metteva poco a leggere quei libri e quei giornali» [7] Leggeva anche i romanzi popolari di Carolina Invernizio e di Anton Giulio Barrili e quelli di Grazia Deledda ma non li apprezzava, considerando folkloristica la visione che della Sardegna ha la scrittice; leggeva «Il Marzocco» e «La Voce» di Giuseppe Prezzolini, Papini, Emilio Cecchi «ma in cima alle sue raccomandazioni, quando mi chiedeva di ritagliare gli articoli e di custodirli nella cartella, stavano sempre Croce e Salvemini». [8]
Alla fine della seconda classe liceale, alla cattedra di lettere italiane del Liceo salì il professor Raffa Garzia, radicale e anticlericale, direttore de «L'Unione Sarda», quotidiano legato alle istanze sardiste rappresentate, in Parlamento da Francesco Cocco-Ortu, allora impegnato in una dura opposizione al ministero di Luigi Luzzatti. Col Garzia Gramsci instaurò un buon rapporto, che andava oltre il naturale discepolato: invitato ogni tanto a visitare la redazione del giornale, ricevette nell’estate del 1910 la tessera di giornalista, con l’invito a «inviare tutte le notizie di pubblico interesse»: e il 25 luglio Gramsci ebbe la soddisfazione di vedersi stampato il suo primo scritto pubblico, venticinque righe di cronaca ironica su un fatto avvenuto nel paese di Aidomaggiore. [9]
In un tema dell'ultimo anno di liceo che ci è conservato, Gramsci scriveva, tra l'altro, che «Le guerre sono fatte per il commercio, non per la civiltà [….] la Rivoluzione francese ha abbattuto molti privilegi, ha sollevato molti oppressi; ma non ha fatto che sostituire una classe all'altra nel dominio. Però ha lasciato un grande ammaestramento: che i privilegi e le differenze sociali, essendo prodotto della società e non della natura, possono essere sorpassate» [10] La sua concezione socialista, qui chiaramente es
pressa, va unita, in questo periodo, all'adesione all’indipendentismo sardo, in una sorta di «socialsardismo», nel quale egli esprimeva, insieme con la denuncia delle condizioni di arretratezza dell’isola e delle disuguaglianze sociali, l’ostilità verso le classi privilegiate del continente, fra i quali venivano compresi, secondo una polemica mentalità di origine contadina, gli stessi operai, concepiti come una corporazione elitaria fra i lavoratori salariati.
Tra poco, Gramsci conoscerà da vicino la realtà operaia di una grande città del Nord: nell'estate del 1911 il conseguimento della licenza liceale con una votazione molto buona – tutti otto e un nove in italiano – gli prospetta la possibilità di continuare gli studi all'Università. Nell’autunno del 1911 il Collegio Carlo Alberto di Torino bandì un concorso, riservato a tutti gli studenti poveri licenziati dai licei del Regno, offrendo 39 borse di studio, ciascuna equivalente a 70 lire al mese per 10 mesi, per poter frequentare l'Università di Torino: Gramsci fu uno dei due studenti di Cagliari ammessi a sostenere gli esami a Torino.
A Torino
Studente universitario

Torino, il loggiato dell'Università
«Partii per Torino come se fossi in stato di sonnambulismo. Avevo 55 lire in tasca; avevo speso 45 lire per il viaggio in terza classe delle 100 avute da casa». Il 27 ottobre 1911 conclude gli esami: li supera classificandosi nono; al secondo posto è uno studente genovese venuto da Sassari, Palmiro Togliatti.
Si iscrive alla Facoltà di Lettere ma le 70 lire al mese non bastano nemmeno per le spese di prima necessità: oltre alle tasse universitarie, deve pagare 25 lire al mese per l’affitto della stanza di Lungo Dora Firenze 57, nel popolare quartiere di Porta Palazzo, e il costo della luce, delle pulizia della biancheria, della carta e dell'inchiostro, e ci sono i pasti – «non meno di due lire alla più modesta trattoria» – e la legna e il carbone per il riscaldamento: privo anche di un cappotto, «la preoccupazione del freddo non mi permette di studiare, perché o passeggio nella camera per scaldarmi i piedi oppure devo stare imbacuccato perché non riesco a sostenere la prima gelata»; [11] sono frequenti le richieste di denaro alla famiglia che però, da parte sua, non se la passa molto meglio.
L'Università di Torino vantava professori di alto livello e di diversa formazione: Luigi Einaudi, Francesco Ruffini, Vincenzo Manzini, Pietro Toesca, Achille Loria, Gioele Solari e poi il giovane glottologo Matteo Bartoli, [12] che si legò di amicizia con Gramsci, come fece anche l'incaricato di letteratura italiana Umberto Cosmo, contro il quale, nel 1920, indirizzò bensì un articolo violentemente polemico, ma nel carcere continuò a ricordarlo con simpatia – «serbo del Cosmo un ricordo pieno di affetto e direi di venerazione [….] era e credo sia tuttora di una grande sincerità e dirittura morale con molte striature di quella ingenuità nativa che è propria dei grandi eruditi e studiosi» [13] – ricordando anche che, con questi e con molti altri intellettuali dei primi quindici anni del secolo, malgrado divergenze di varia natura, egli avesse questo in comune: «partecipavamo in tutto o in parte al movimento di riforma morale e intellettuale promosso in Italia da Benedetto Croce, il cui primo punto era questo, che l'uomo moderno può e deve vivere senza religione rivelata o positiva o mitologica o come altro si vuol dire. Questo punto anche oggi mi pare il maggior contributo alla cultura mondiale che abbiano dato gli intellettuali moderni italiani». [14]

Angelo Tasca
È a casa per le elezioni politiche del 26 ottobre 1913, nell'Italia in guerra contro la Turchia per la conquista della Libia; votano, per la prima volta, anche gli analfabeti, ma la corruzione e le intimidazioni sono le stesse delle elezioni precedenti. Il timore che l'allargamento della base elettorale favorisse i socialisti portò al blocco delle candidature di tutte le forze politiche contro i candidati socialisti, indicati come il comune nemico da battere. In questo obbiettivo, «sardisti» e «continentali» si trovarono d'accordo e deposero le vecchie polemiche. Gramsci scrisse di quest'esperienza elettorale al compagno di studi Angelo Tasca, giovane dirigente socialista torinese, il quale affermò Gramsci «era stato molto colpito dalla trasformazione prodotta in quell'ambiente dalla partecipazione delle masse contadine alle elezioni, benché non sapessero e non potessero ancora servirsi per conto loro della nuova arma. Fu questo spettacolo, e la meditazione su di esso, che fece definitivamente di Gramsci un socialista». [15]
Tornò a Torino ai primi di novembre del 1913, andando ad affittare una stanza all'ultimo piano del palazzo di via San Massimo 14, oggi Monumento nazionale; dovrebbe datarsi a questo periodo la sua iscrizione al Partito socialista. Si trovò in ritardo con gli esami, con il rischio di perdere il contributo della borsa di studio, a causa di «una forma di anemia cerebrale che mi toglie la memoria, che mi devasta il cervello, che mi fa impazzire ora per ora, senza che mi riesca di trovare requie né passeggiando, né disteso sul letto, né disteso per terra a rotolarmi in certi momenti come un furibondo». Riconosciuto «afflitto da grave nevrosi» gli fu concesso di recuperare gli esami nella sessione di primavera. [16]
Prese anche lezioni private di filosofia dal professor Annibale Pastore, il quale scrisse poi che «il suo orientamento era originalmente crociano ma già mordeva il freno e non sapeva ancora come e perché staccarsi [….] voleva rendersi conto del processo formativo della cultura agli scopi della rivoluzione [….] come fa il pensare a far agire [….] come le idee diventano forze pratiche». Gramsci stesso scriverà di aver sentito anche la necessità di «superare un modo di vivere e di pensare arretrato, come quello che era proprio di un sardo del principio del secolo, per appropriarsi un modo di vivere e di pensare non più regionale e da villaggio, ma nazionale» ma anche «di provocare nella classe operaia il superamento di quel provincialismo alla rovescia della palla di piombo [come il Sud Italia era generalmente considerato nel Nord] che aveva le sue profonde radici nella tradizione riformistica e corporativa del movimento socialista». [17]
L'iscrizione al partito gli permise di superare in parte un lungo periodo di solitudine: o
ra frequentava i giovani compagni di partito, fra i quali erano Tasca, Togliatti, Terracini: «uscivamo spesso dalle riunioni di partito [….] mentre gli ultimi nottambuli si fermavano a sogguardarci [….] continuavamo le nostre discussioni, intramezzandole di propositi feroci, di scroscianti risate, di galoppate nel regno dell'impossibile e del sogno». [18]
Nell'Italia che ha dichiarato la propria neutralità nella Prima guerra mondiale in corso – neutralità affermata anche dal Partito socialista – scrive [19] per la prima volta sul settimanale socialista torinese Il Grido del popolo, il 31 ottobre 1914, l'articolo Neutralità attiva e operante in risposta a quello apparso il 18 ottobre sull' «Avanti!» di Mussolini Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva e operante, senza però poter comprendere quale svolta politica stesse preparando l'allora importante e popolare esponente socialista.
Sostenne il 13 aprile 1915 quello che sarà, senza che lo sapesse ancora, il suo ultimo esame all'Università; il suo impegno politico si fece crescente con l'entrata in guerra dell'Italia e con il suo ingresso nella redazione torinese dell'«Avanti!».
L'attività giornalistica: il critico teatrale

Torino, la Mole Antonelliana
Dal 1916 gran parte della giornata di Gramsci trascorse all’ultimo piano nel palazzo dell’Alleanza Cooperativa Torinese al numero 12 di corso Siccardi (oggi Galileo Ferraris), dove, in tre stanze, erano situate la sezione giovanile del partito socialista e le redazioni del Grido del popolo e del foglio piemontese dell’ Avanti!, che comprendeva la rubrica della cronaca torinese, Sotto la Mole; in entrambi i giornali Gramsci pubblicava di tutto, dai commenti sulla situazione interna ed estera agli interventi sulla vita di partito, dagli articoli di polemica politica alle note di costume, dalle recensioni dei libri alla critica teatrale. Dirà più tardi di aver scritto in dieci anni di giornalismo, «tante righe da poter costituire quindici o venti volumi di quattrocento pagine, ma esse erano scritte alla giornata e dovevano morire dopo la giornata» [20] e di aver contribuito «molto prima di Adriano Tilgher» a rendere popolare il teatro di Pirandello: «ho scritto sul Pirandello, dal 1915 al 1920, tanto da mettere insieme un volumetto di duecento pagine e allora le mie affermazioni rano originali e senza esempio: il Pirandello era o sopportato amabilmente o apertamente deriso». [21]
Sono 168 le note di critica teatrale stilate da Gramsci per l'«Avanti!» dal gennaio 1916 al dicembre 1920. Si tratta di brevi articoli dove, riassunta la trama e valutata l'interpretazione degli attori, Gramsci esprime sull'autore e sull'opera il proprio giudizio in poche righe chiare e pregnanti, secondo un'estetica che si potrebbe definire marxistica-crociana.
Così, a proposito de «La nemica» di Niccodemi, scrive, tra l'altro: «Dario Niccodemi si è costruito un mito teatrale. Ed esso serve a spiegare in gran parte il successo spettacoloso dei lavori del fortunato scrittore italo-francese. Viene da ripensare alle idee di Riccardo Wagner sul dramma musicale, e al suo rifugiarsi nella mitologia medievale germanica, per poter dare il massimo di realismo poetico alle creature della sua fantasia, per rendere più sostanzialmente suggestiva la sua musica, trasportando l'uditorio in un mondo soprannaturale, nel quale il linguaggio musicale sia immaginato possibile e naturalissimo. Ma ciò che nel Wagner è ricerca affannosa di maggiore sincerità fantastica, nel Niccodemi è mezzo di successo. Il suo mondo mitologico è l'aristocrazia, il pubblico che affolla i teatri e rende redditizia la professione di scrittore drammatico è la piccola borghesia. L'insincerità di Dario Niccodemi cerca la sua giustificazione, cerca di rendersi naturale e possibile mitizzandosi. Una idea morale, elementarissima, o che riesca a far presa subito sul pubblico sentimentale, pronto a commuoversi e a diventare salice piangente, diventa sostanza di dramma non per forza propria, per la sua profonda umanità, ma perché serve di cauterio e stacca due classi, due concezioni quanto mai fittizie e artificiali: quella aristocratica e quella piccolo-borghese. Gli urti che ne derivano, i discorsi che è possibile far fare, le predichette, tutta la cattiva letteratura degli scrittori sociali del basso romanticismo francese come Eugenio Sue o Dumas figlio, si dànno accolta e toccano il cuore e strappano l'applauso. Così nell' Aigrette, così in questa nuovissima Nemica». [22]
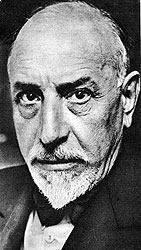
Luigi Pirandello
Della commedia di Pirandello Pensaci, Giacomino! scrisse [23] che «è tutto uno sfogo di virtuosismo, di abilità letteraria, di luccichii discorsivi. I tre atti corrono su un solo binario. I personaggi sono oggetto di fotografia piuttosto che di approfondimento psicologico: sono ritratti nella loro esteriorità più che in una intima ricreazione del loro essere morale. È questa del resto la caratteristica dell'arte di Luigi Pirandello, che coglie della vita la smorfia, più che il sorriso, il ridicolo, più che il comico: che osserva la vita con l'occhio fisico del letterato, più che con l'occhio simpatico dell'uomo artista e la deforma per un'abitudine ironica che è l'abitudine professionale più che visione sincera e spontanea», memtre considerò Liolà [24] «il prodotto migliore dell'energia letteraria di Luigi Pirandello. In esso il Pirandello è riuscito a spogliarsi delle sue abitudini retoriche. Il Pirandello è un umorista per partito preso [….] troppo spesso la prima intuizione dei suoi lavori viene a sommergersi in una palude retorica di una moralità inconsciamente predicatoria, e di molta verbosità inutile».
Il fu Mattia Pascal, secondo Gramsci, è una sorta di prima stesura del Liolà che, liberato dalla zavorra moralistica del romanzo, si è rinnovato diventando una pura rappresentazione, «una farsa che si riattacca ai drammi satireschi della Grecia antica, e che ha il suo corrispondente pittorico nell'arte figurativa vascolare [….] è una vita ingenua, rudemente sincera [….] una efflorescenza di paganesimo naturalistico, per il quale la vita, tutta la vita è bella, il lavoro è un'opera lieta, e la fecondità irresistibile prorompe da tutta la materia organica».
Severo fu invece il giudizo sul Così è (se vi par
e): [25] dalla tesi – pseudologistica – che la verità in sé non esista, Pirandello «non ha saputo trarre dramma [….] e neppure motivo a rappresentazione viva e artistica di caratteri, di persone vive che abbiano un significato fantastico, se non logico. I tre atti di Pirandello sono un semplice fatto di letteratura [….] puro e semplice aggregato di parole che non creano né una verità né un'immagine [….[ il vero dramma l'autore l'ha solo adombrato, l'ha accennato: è nei due pseudopazzi che non rappresentano però la loro vera vita. l'intima necessità dei loro atteggiamenti esteriori, ma sono presentati come pedine della dimostrazione logica».
- ^ Incidentalmente, Gramsci scrisse dal carcere, il 12 ottobre 1931, alla cognata Tatiana Schucht, delle diverse origini dei suoi antenati: per parte paterna, i Gramsci sarebbero giunti in Italia dall’Epiro «durante o dopo il 1821», e per parte materna, la nonna «discendeva da qualche famiglia italo-spagnola dell’Italia meridionale». Tuttavia, ricerche d’archivio hanno dimostrato che il bisnonno Nicola Gramsci nacque a Napoli il 31 dicembre 1769, figlio di Gennaro e di Domenica Blajotta, smentendo o retrodatando di molto l’eventuale origine albanese dei Gramsci
- ^ Così Gramsci ricordava con ironia l'episodio, nella lettera dal carcere alla cognata Tatiana, il 7 settembre 1931, aggiungendo che «una zia sosteneva che ero risuscitato quando lei mi unse i piedini con l'olio di una lampada dedicata a una madonna e perciò, quando mi rifiutavo di compiere gli atti religiosi, mi rimproverava aspramente, ricordando che alla madonna dovevo la vita»
- ^ «Noi eravamo tutti molto piccoli. Lei dunque doveva anche accudire alla casa. Trovava il tempo per i lavori di cucito rinunziando al sonno». Così ricordava quegli anni la sorella Teresina Gramsci, in G. Fiori, Vita di Antonio Gramsci, p. 18
- ^ Lettera a Tatiana Schucht, 3 ottobre 1932: così Gramsci scriveva per invitare la cognata a non eccedere nelle sue preoccupazioni sulla sua vita di carcerato. La lettera prosegue infatti: «Ho conosciuto quasi sempre solo l’aspetto più brutale della vita e me la sono sempre cavata, bene o male»
- ^ Lettera a Tatiana Schucht, 12 settembre 1932
- ^ Numerose sono le richieste di denaro al padre: il 10 febbraio 1910 gli scrive di essere «proprio indecente con questa giacca che ha già due anni ed è spelacchiata e lucida [….] oggi non sono andato a scuola perché mi son dovuto risuolare le scarpe» e, il 16 febbraio, che «per non farvi vergognare non sono uscito di casa per dieci giorni interi»
- ^ Testimonianza in G. Fiori, cit., p.65
- ^ Testimonianza della sorella Teresina in G. Fiori, cit., p. 66
- ^ L’articolo è riportato in G. Fiori, cit., p. 69
- ^ Riportato in A. Gramsci, Scritti politici, p. 53-55
- ^ A. Gramsci. Lettere. 1908-1926, p. 55
- ^ Progettando, in carcere, uno studio di linguistica comparata, mai realizzato, in una lettera dal carcere del 19 marzo 1927 alla cognata Tatiana, ricorda come «uno dei maggiori "rimorsi" intellettuali della mia vita è il dolore profondo che ho procurato al mio buon professor Bartoli dell'Università di Torino, il quale era persuaso essere io l'arcangelo destinato a profligare definitivamente i "neogrammatici"» della linguistica
- ^ Lettera dal carcere del 23 febbraio 1931: in essa Gramsci ricorda ancora un simpatico e patetico episodio. Dopo la rottura avvenuta ala fine del 1920, a causa di quell'articolo che fece «piangere come un bambino e stette chiuso in casa [il Cosmo] per alcuni giorni», essi s'incontrarono nel 1922 nell'Ambasciata d'Italia a Berlino, dove il professore era segretario: «il Cosmo mi si precipito addosso, inondandomi di lacrime e di barba e dicendo a ogni momento: Tu capisci perché! Tu capisci perché! Era in preda a una commozione che mi sbalordì, ma mi fece capire quanto dolore gli avessi procurato nel 1920 e come egli intendesse l'amicizia per i suoi allievi di scuola»
- ^ Lettera dal carcere a Tatiana Schucht del 17 agosto 1931
- ^ In G. Fiori, cit., p. 103
- ^ In G. Fiori, cit., p. 105
- ^ In G. Fiori, cit., 108-109
- ^ In G. Fiori, cit., 112
- ^ In A. Gramsci, Scritti politici, I, p. 56-59
- ^ Lettera dal carcere a Tatiana Schucht del 7 settembre 1931
- ^ Lettera dal carcere a Tatiana Schucht del 19 marzo 1927
- ^ Recensione del 9 novembre 1916
- ^ Recensione del 24 marzo 1917
- ^ Recensione del 4 aprile 1917
- ^ Recensione del 5 ottobre 1917
Tratto da http://it.wikipedia.org